Bimbe "fantasma": nuovi dati ridimensionano tutto, vogliamo parlarne?
Scompaiono 132 fantasmi l’anno, per “La Repubblica” non è una (bella) notizia
“Ho chiamato al telefono le comunità”
“E hai trovato occupato?”
(dal film “Straziami ma di baci saziami”,
con una lieve variante)
 Costretti a tornare sul tema degli aborti selettivi, veri e presunti, ne chiediamo scusa al lettore. Lavorare su (e ricordare agli altri) tante meschinità dette e ripetute non ci diverte.
Costretti a tornare sul tema degli aborti selettivi, veri e presunti, ne chiediamo scusa al lettore. Lavorare su (e ricordare agli altri) tante meschinità dette e ripetute non ci diverte.
Da 165 a 33, senza neanche dire: ho fatto un lieve errore di calcolo
“La Repubblica di Firenze” torna sul tema, giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Riporta dati ufficiali comunicati dalla Regione Toscana, ripetendo una serie di considerazioni, di cui alcune discutibili. I toni si abbassano, ma i cronisti sembrano aver dimenticato le cifre già prodotte, ed evitano di confrontarle con quelle ufficiali.
E’ un conteggio che facciamo qui. Lo slogan delle “500 mai nate” (con contorno stigmatizzante di “strage” e toni patetici a dir poco stonati) proveniva da una stima, condotta dal giornale su suggestione di pochi dati riguardanti la Toscana riportati nel libro di Anna Meldolesi, di 165 mancati parti di bambine l’anno, per tre anni.
I dati ufficiali dell’Agenzia regionale di sanità, che riguardano gli ultimi 5 anni, fanno scendere la cifra stimata delle “neonate mancanti” (tutte virtuali e non vittime di strage, perché si tratta del distacco statistico tra il rapporto maschi-femmine alla nascita in tutto il mondo e quello m/f nati da immigrate cinesi, indiane, albanesi in Toscana negli ultimi 5 anni) a circa 33 l’anno. I cronisti de “La Repubblica-Firenze” evidentemente ritengono che aver moltiplicato, in un contesto di allarme sociale suscitato verso popolazioni minoritarie, con la sottolineatura della loro chiusura e diversità, per 5 il numero più attendibile sia segno di professionalità.
Non si indaga sulle responsabilità, si preferisce la stigmatizzazione di popolazioni intere
Si dirà che anche una sola bambina (e non 33, o 165) non messa al mondo è un segno di ingiustizia, e forse un crimine. E’ vero, con l’avvertenza che di quel presunto crimine vanno indagate meglio le responsabilità, componente per componente, se non altro per evitarne la ripetizione. Per esempio, una legge cinese del 1979 (quella sul figlio unico) è tra le maggiori responsabili della preferenza data al figlio maschio, in Cina, e parzialmente forse altrove, contribuisce a influenzare comportamenti di una minoranza di famiglie cinesi in emigrazione. Altre, dicono di esser venute via dalla Cina anche per quella legge. Si può provare a cercare di capire.
Ma per quanto riguarda l’allarme sociale, la stigmatizzazione e la chiusura di migliaia di donne nelle gabbie mentali delle “comunità”, passare da 33 a 165 un effetto ce l’ha, e non secondario.
Reputarsi distinti, risultare banali: “sex-ratio”, “comunità”, etc.
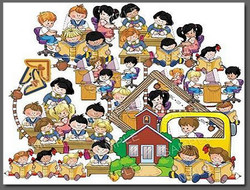 Tutto concentrato sulla “sex ratio” (ah, il fascino del neoslogan dal sapore anglo-latino!), il cronista Michele Bocci non batte ciglio nel menzionare un altro dato, che probabilmente indica un enorme disagio sociale, tutto da indagare - mica da parte di “Repubblica”, per carità! – a meno di non volere immaginare che le donne romene siano “propense” culturalmente all’aborto (come i maschi della stessa nazionalità allo stupro, secondo una famigerata espressione di un cultore di scienze statistiche, Luca Ricolfi). Ancora più famigerata, oggi 10 dicembre, mentre stanno ancora bruciando le povere abitazioni di rom, a Torino, in seguito a uno stupro immaginario attribuito a due rom.
Tutto concentrato sulla “sex ratio” (ah, il fascino del neoslogan dal sapore anglo-latino!), il cronista Michele Bocci non batte ciglio nel menzionare un altro dato, che probabilmente indica un enorme disagio sociale, tutto da indagare - mica da parte di “Repubblica”, per carità! – a meno di non volere immaginare che le donne romene siano “propense” culturalmente all’aborto (come i maschi della stessa nazionalità allo stupro, secondo una famigerata espressione di un cultore di scienze statistiche, Luca Ricolfi). Ancora più famigerata, oggi 10 dicembre, mentre stanno ancora bruciando le povere abitazioni di rom, a Torino, in seguito a uno stupro immaginario attribuito a due rom.
Viene a sapere, infatti, il Bocci, e ripete pari pari, che presso le romene le interruzioni di gravidanza sono 874 su mille nati (192 tra le donne italiane, 300 tra le cinesi); e aggiunge: “ma la sex ratio in questa comunità non si scosta dalla media”. Perciò: tranquilli! (1)
Appare sintomatico come, di fronte a un dato che da solo ridicolizza una categoria(la “comunità”), o almeno dovrebbe introdurre dei dubbi sul suo uso, a quella categoria fatua ci si appigli. Il reale viene esorcizzato, ripetendo ossessivamente lo slogan della “appartenenza comunitaria”. Se le donne romene in Toscana avessero attorno davvero una comunità, con le risorse solidaristiche che offre, i vincoli e i controlli che ne derivano, davvero sarebbero costrette a più di un’interruzione ogni tre gravidanze?
Da anni studiosi e attivisti ammoniscono a non adoperare la categoria della “comunità immigrata”, pena il non capirci proprio nulla. Anche chi adoperava questo termine per suggestione religiosa si è accorto di tale rischio, e per esempio i Dossier Caritas-Migrantes per evitarlo nelle statistiche parlano oggi di “collettività”. Ma la pigrizia di uomini politici, amministratori e (soprattutto?) giornalisti non apprezza dubbi cognitivi. Alla larga dalle possibilità di conoscere!
A che serve dire “comunità”
Quando si avverte della inutilità, futilità, banalità del termine “comunità” non si tratta di una petizione di principio; al contrario, proprio gli studi più attenti hanno spinto in questa direzione. Le “comunità” possono essere il risultato dell’azione congiunta di un riconoscimento (a pesanti condizioni) delle nuove presenze, e di una rivendicazione di appartenenza da parte di chi, nell’interazione con un ambiente non accogliente, se non proprio ostile, è portato a mettere in scena una “identità esternata”, che non va confusa da parte dell’osservatore con la “identità esperita” (Fabietti). L’identità etnica si costruisce solo nell’interazione sociale (Gallini) e il senso di comunità viene così spesso attribuito che rischia di essere indotto. Ma a chi conviene, produrlo e potenziarlo?
Per quanto riguarda i romeni, per esempio, tali dinamiche sono indagate nitidamente in una ricerca condotta a Torino da Pietro Cingolani e pubblicata due anni fa dall’editore Il Mulino. Basterebbe leggerne le pp.128-138 per abbandonare l’uso del termine “comunità”; a meno che non lo si avverta come redditizio proprio per la sua inappropriatezza.
Come avrà fatto l’assessore a chiedere aiuto alle comunità?
Una riprova dell’attaccamento allo spettro della “comunità” la dà l’altra cronista, Laura Montanari, quando scrive che l’assessore Scaramuccia “aveva chiesto aiuto ad amministrazioni locali e comunità per intercettare il fenomeno”. Francamente, dubito che l’assessore abbia parlato così. Invito il lettore a tentare di immaginare come si faccia a “chiedere aiuto alle comunità”. E’ possibile (e auspicabile) che Scaramuccia abbia consultato testimoni privilegiati, soprattutto donne, sia di cittadinanza cinese, albanese, indiana che italiana (due tra queste ultime, è una fortuna che lavorino in Toscana, Maria Omodeo e Antonella Ceccagno). Difficile che abbia “parlato” con “comunità”, enti che vivono solo nel discorso di senso comune, non hanno una rappresentanza ufficiale (nonostante alcune autoproclamazioni, giustamente relativizzate dagli amministratori non sprovveduti, e che comunque non riguardano cittadini di origine indiana, albanese e cinese).
Non è difficile venire a sapere che le varie associazioni di cinesi presenti sul territorio non hanno la pretesa di rappresentare la “comunità” cinese, ma solo la parte associata, per finalità, obiettivi e interessi espliciti e riconoscibili.
Nel caso dei cittadini di origine albanese, sono disponibili numerose ricerche che concordano sulla pluralità dei motivi di coesione e di reti sociali tra provenienti dall’Albania e dall’elusione di una autorappresentazione in termini di appartenenza “comunitaria”.
E’ stata proprio questa strategia di rifiuto della messa in scena identitaria che ha permesso a tanti cittadini di origine albanese prima di resistere alla stigmatizzazione, poi di dissipare la coltre di equivoci e stereotipi che li penalizzavano sul lavoro, nella ricerca di case, nelle relazioni con i vicini. Tutto questo, nonostante l’orgoglio della propria storia e le spinte sociocentriche inevitabili in alcune fasi della migrazione. Per questo, parlare di “comunità albanese” è regressivo e inefficace. Istituisce fantasmi, a cui non è facile parlare, né tanto meno “chiedere aiuto”.
Perché non ci si chiede su quali cause dell’aborto selettivo si può intervenire?
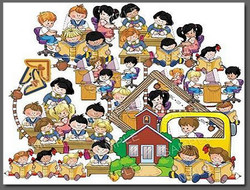 Un’altra questione che colpisce è la mancanza, negli articoli su “Repubblica”, di attenzione alle ragioni concrete per cui è possibile che una donna compia, o sia costretta a compiere, un aborto selettivo. Dopo un rapido accenno, nel primo intervento della campagna, a “motivi storici”, con l’intervento di Galati si passa a privilegiare una interpretazione tutta ideologica: “Capirne i motivi conduce facilmente a ricordare le culture da cui provengono e il ruolo delle famiglie, che spesso sono fortezza in un mondo alieno, ma anche prigione per chi vuole aprirsi al Paese che ospita”. Non ho tagliato nulla, del periodo di Galati, che scrive davvero così: “Capirne i motivi conduce facilmente a ricordare le culture..”.
Un’altra questione che colpisce è la mancanza, negli articoli su “Repubblica”, di attenzione alle ragioni concrete per cui è possibile che una donna compia, o sia costretta a compiere, un aborto selettivo. Dopo un rapido accenno, nel primo intervento della campagna, a “motivi storici”, con l’intervento di Galati si passa a privilegiare una interpretazione tutta ideologica: “Capirne i motivi conduce facilmente a ricordare le culture da cui provengono e il ruolo delle famiglie, che spesso sono fortezza in un mondo alieno, ma anche prigione per chi vuole aprirsi al Paese che ospita”. Non ho tagliato nulla, del periodo di Galati, che scrive davvero così: “Capirne i motivi conduce facilmente a ricordare le culture..”.
Provo a liberare la prosa da contorsioni che sono anche sintomi: “invece di cercare di capire, è più facile prendere la strada della cultura come spiegazione”. Ora, si dà il caso che negli ultimi decenni l’antropologia abbia chiarito definitivamente che “la cultura non è un dato che informa la vita di coloro che la condividono” (Wagner, “The Invention of Culture”, 1975). La via facile scelta da Galati (spiegare i motivi dell’aborto selettivo attraverso la ”cultura”) si rivela perciò una scorciatoia di comodo, che non porta da nessuna parte: dove infatti si voleva arrivare.
Non si vuol qui negare che, venendo dalla Cina o dall’India, i motivi per cui per un certo periodo (che può variare, secondo i motivi, da millenni a pochi anni) si preferisce avere un maschio, e che possono essere analoghi, se non tutti almeno in buona parte, a simili tendenze presenti altrove, possano in parte continuare ad avere una forza inerziale; al contrario, riteniamo possibile che addirittura possano essere potenziati dalle condizioni di vita praticabili nella società di arrivo. Ma se questi motivi, queste variabili di potenza e radicamento diversi, vengono ricondotti a una “cultura” - che è uno schema rigido nella testa del, o della, giornalista che scrive un libro o ne riparla su un giornale - come faremo a ridurne l’efficacia?
Esaltando le (presunte) culture, si nasconde il (declinante) welfare
Si può fare un esempio, come si dice, accademico, astratto (ma non troppo) e per provare a ragionarci (almeno in parte).
Si consideri un gruppo di famiglie che vengono da una zona in cui si pratica di sicuro l’aborto selettivo, per una serie di cause. Poniamo, per non toccare un esempio più caldo per la Toscana,, che vengano dal Panjab.
I dati delle immigrate dal Punjab in Toscana sono pressoché irrilevanti, ma se prendiamo tutti i parti di donne provenienti dal Panjab in Italia, presenti soprattutto nella bassa padana, per dieci anni, è probabile che ci si trovi davanti un campione significativo, e prevedibilmente (a partire dai pochi dati che posso conoscere, per esempio, sulle provincie di Cremona e Lodi) saremo di fronte alla possibilità che si siano praticati aborti selettivi, a favore dei maschi.
Poniamo, sempre per ipotesi, che si voglia veramente ridurre tale fenomeno. Sarà meglio individuare il diorama delle concause (come diceva da giovane un lettore di Leibniz, diventato poi uno scrittore famoso) che concorrono alla desiderabilità di avere un figlio maschio. Nell’elenco di tali concause, dotate, certo, di diverso peso e resistenza diversa, alcune saranno di più lunga durata (ma forse non “radicate” solo nella “cultura” Sikh), altre di più recente origine. Alcune saranno già state messe in questione dall’inserimento nella società di accoglienza, dall’interazione con diversi modelli e stili di vita, combinati magari con una serie di condizioni economiche e di aspettative istituzionalmente offerte sul territorio.
 Sottovalutare tale adattamento alla società di accoglienza può condurre ad abbagli divertenti, o drammatici, secondo i punti di vista. Per esempio, l’adattamento delle migranti al modello riproduttivo della società italiana procede a ritmo assai più veloce di quanto molti demografi non avessero previsto pochissimi anni fa, magari perché nelle loro statistiche non consideravano la variabile “adattamento al modello della società ospite”, preferendo cullarsi in una presunta fissità “culturale”.
Sottovalutare tale adattamento alla società di accoglienza può condurre ad abbagli divertenti, o drammatici, secondo i punti di vista. Per esempio, l’adattamento delle migranti al modello riproduttivo della società italiana procede a ritmo assai più veloce di quanto molti demografi non avessero previsto pochissimi anni fa, magari perché nelle loro statistiche non consideravano la variabile “adattamento al modello della società ospite”, preferendo cullarsi in una presunta fissità “culturale”.
Se ne accorge un demografo illustre, Blangiardo, che sul XVI Rapporto ISMU rileva come il numero medio di figli per donna nella popolazione straniera presente in Italia (ovvero il tasso di fecondità totale su quella popolazione) sia sceso dal 2,50 del 2006 al 2,05 del 2009. E aggiunge, saggiamente, Blangiardo: “la bassa fecondità non ha nazionalità quando si condividono le ben note difficoltà nel far crescere la famiglia, soprattutto in un grande contesto metropolitano” (XVI Rapporto, p.40). (Mancanza di) welfare, non cultura.
A volte, imprigiona di più il mercato del lavoro che la famiglia (anche per gli immigrati)
Una volta informati su questa riduzione dei figli per donna, è possibile immaginare che la società ospite influisca più rapidamente su alcune scelte familiari (avere figli) che su altre (preferire il maschio fino all’aborto selettivo, in una minoranza di casi). In questo modo si rischierebbe di fare rientrare dalla porta dell’ideologia una inerzia “culturale” che era stata buttata via dalla finestra delle considerazioni pratiche. Perché nella scelta di privilegiare il maschio non dovrebbero influire, anche e notevolmente, considerazioni pratiche che fingiamo di non vedere?
Per esempio, siamo così sicuri che (1) la riforma delle pensioni che si discute in parlamento, insieme a (2) un mercato del lavoro fortemente etnicizzato e lui, sì, imprigionante, che offre al giovane sikh la stessa mansione (mungitura di mucche) che ha offerto al babbo, e pochissimo alla sorella, e a (3) una scuola che accoglie male chi vien da fuori e non facilita la mobilità sociale, non possa contribuire a spingere le future famiglie sikh a cercare di costruirsi un sostegno più sicuro, rispetto a pensioni misere e temporalmente assai lontane, e a essere tentate dall’attuare una selezione riproduttiva, di quelle che magari sono in via di diminuzione per soli motivi “culturali”?
Forse è meglio, per chi voglia governare i fenomeni, ragionare in termini sistemici, e su variabili meno paludose delle “radici culturali”.
Identità ascritte e attribuzione dei mali sociali
 Uno studente universitario di sociologia può imparare dai manuali di base che “l’identità collettiva desunta dall’origine geografica diventa caratterizzante e appiattisce le differenze individuali” (Ambrosini, “Sociologia delle migrazioni”, Il Mulino, p.91), e che le “differenze etniche” sono “l’esito di interazioni tra gruppi” e perciò “inevitabilmente arbitrarie” (Zanfrini, “Sociologia delle migrazioni”, Laterza, p.5). Potrebbe impararlo anche un apprendista cronista.
Uno studente universitario di sociologia può imparare dai manuali di base che “l’identità collettiva desunta dall’origine geografica diventa caratterizzante e appiattisce le differenze individuali” (Ambrosini, “Sociologia delle migrazioni”, Il Mulino, p.91), e che le “differenze etniche” sono “l’esito di interazioni tra gruppi” e perciò “inevitabilmente arbitrarie” (Zanfrini, “Sociologia delle migrazioni”, Laterza, p.5). Potrebbe impararlo anche un apprendista cronista.
Ma rischierebbe di leggere brani del genere: “Lo studio del fenomeno migratorio rende consapevoli della tendenza ad assegnare ai migranti una posizione socialmente svantaggiata (…) e della propensione a considerarli responsabili di mali e inadeguatezze che in realtà riguardano la società ospite e che i migranti non fanno altro che rendere palesi” (Zanfrini, p.V).
Se consapevole di queste possibilità, potrebbe poi il cronista abbandonarsi a strizzare l’occhio al senso comune più balordo, e contribuire ad allarmarlo e incattivirlo?
La domanda non è retorica, anzi: dalla risposta ad essa discende il senso, o meno, del presente tentativo di informazione.-

